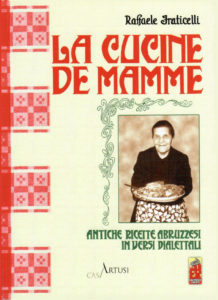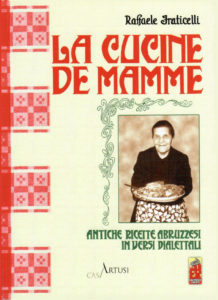
Antiche ricette abruzzesi in versi dialettali
Dedica: Agli abruzzesi di ieri, di oggi, di domani
Immagine di copertina: Nonna Melania, madre dell’autore – Foto di Paolo Fraticelli, 1972
Anno di Pubblicazione: 2015 – èDICOLA Editrice
PRESENTAZIONE
Alberto Capatti
Storico della gastronomia Comitato Scientifico di Casa Artusi
E Artusi sorride …
La cucina si faceva in silenzio, collo sfrigolar della padella o il crepitio d’un focolare. Ma la sua comunicazione era orale e la si insegnava parlando, e per non perderne memoria, qualcuno, non la serva, provvedeva ad annotare su un foglio la ricetta. La stampa veniva molto dopo, eventualmente, non sempre. La cucine de mamme sembra prendere avvio dalla voce, dalle voci, con uno strano percorso che passa attraverso la radio e finisce stampata in versi abruzzesi. Anche la radio non è d’ieri: le ricette erano recitate in Francia dagli anni ’20, in Italia un decennio dopo. A ripeterle ancor oggi è Raffaele Fraticelli che le ha viste dal vivo ascoltate scritte riscritte in versi radiofonate e concesse alle stampe. Un percorso unico attraverso tutte le fasi della comunicazione culinaria e casalinga, con il televisore spento. Per questa ragione Casa Artusi si è incuriosita.
Il dialetto – poco importa se milanese, romagnolo o abruzzese – avrebbe dovuto turbare l’ascolto, la comprensione, come certi crepitii, gracidii delle enormi radio d’una volta. E invece nulla, potete leggere senza pregiudizi. Non sei abruzzese ma hai ne La cucine de mamme un glossario stampato, o, davanti a te, c’è un computer e puoi approfondire il significato dei vocaboli con lessici, ricette ed immagini, stupito di ritrovare brulicante in un altro mondo l’oggetto di studio di Raffaele Fraticelli. Ti manca la voce di Raffaele, ma non perdi il filo e ritrovi nel dialetto, nel costrutto poetico, una dimensione originaria della cucina di casa, tradotta sì, sempre più frequentemente, in italiano, ma qui libera da neologismi e da fotografie stucchevoli. Leggendo, pensavo alla casa di un Artusi diciottenne, nella piazza della Rocca di Forlimpopoli, e ascoltavo la madre Teresa Giunchi istruire la serva, o annunciare dei ravioli all’uso di Romagna al figlio il quale non si sarebbe mai sognato, a quell’età, di ritrovarli molto a sud del suo paese, con il nome di raviule de recotte.
Altro punto e non da poco, ritroverete, leggendo, non solo specialità abruzzesi diffuse nel mondo, i maccarune a la chetarre – Eugenio Medagliani milanese vende da anni “chitarre” ai giapponesi – ma piatti che appartengono al patrimonio regionale italiano, declinati qua e là con ingredienti simili o dissimili, con esiti saporosi peculiari o personali. Cotiche e fagioli sono fra questi, romani anzitutto, ma non disprezzati dai milanesi che la codega hanno sempre amato (salvo poi mescolare riso e fagioli). Possiamo immaginare che Artusi, sempre giovinetto, seduto a tavola, si vedesse servire un piattone di codga e fasul senza sospettarne le varietà linguistiche, nord-sud, est-ovest. Questo appunto conferma che i fasciule nghe le còteche rientrano nella cucina italiana, rendendo ben comprensibile il dettato abruzzese, ma suggerendo, di proprio, un soffrittino finale di cipolla, prosciutto e pomodori. Ma così non fan tutte (le mamme).
Una volta inserito questo ricettario in versi in un repertorio di più ampio respiro ove coesistono dialetti, prodotti, cotture e idee fisse delle singole cuoche, bisogna misurarne la temporalità, fare il calcolo degli anni. La cucina di mamma afferisce a una o più generazioni, e implicitamente suggerisce l’idea che le pratiche domestiche, tramandandosi, divengano “tradizione”. Ebbene, l’originalità di Raffaele Fraticelli sta nell’aver parlato dalla radio non per far credere ad un tempo immemorabile in cui serve, nonne e mamme dialettavano di concerto, ma per ricollocarle in un contesto più preciso ed attuale. Che altra ricetta dobbiamo citare se non quella degli spaghitte a la carbunare. Attestata solo a partire degli anni ’50, fa parte, oggi, del repertorio creato da signore ottanta-novantenni, e riteniamo la versione abruzzese come un caso da approfondire. Ma Artusi non può più aiutarci – i carbuner e la carbunera romagnoli non varcano la soglia della cucina – anche se amava gli spaghetti (dieci ricette), prediligeva il lardo, e privava pollai e galline di un numero impressionante di uova.
Il professore dirà, a questo punto, che varietà linguistiche e culinarie sono da approfondire incrociandole, datandole, appuntandole su una carta geografica. L’accademico e il dilettante colto ripeteranno, cinti di un grembiule, un verso qui ed uno là, facendo ridere, se lombardi o romagnoli, gli amici abruzzesi. Le cuoche continuano, dopo una sbirciatina alla ricetta, a tirar dritto, serie serie, sorvegliando i fagioli che bollono o il soffritto che sfrigola. Va da sé che, in uno scenario surreale, Artusi sorride compiaciuto.
PREFAZIONE
Ottaviano Giannangeli
Dalla prima edizione del 1978
FRATICELLI, O DELLA SAGGEZZA CULINARIA ABRUZZESE
Dopo Abruzzo, un profilo storico di Raffaele Colapietra, la Sede regionale d’Abruzzo della Rai patrocina la pubblicazione de La cucine de mamme di un altro Raffaele (quando si dice della fortuna di un nome! …): questa volta Fraticelli.
Raffaele Fraticelli è un personaggio popolare della Rai regionale, forse il più popolare. Una volta impersonava l’astuto abruzzese “Zì Carminuccio”, che aveva una valenza traumatica, una forza di rottura nei nostri microfoni: era l’abruzzese che faceva valere la sua virtù contestativa nei confronti di una civiltà tecnologica e meccanizzata, consumistica, in nome di una sapienza antica che si esprimeva attraverso le salaci battute del monologo dialettale: in fìn dei conti, una maschera. Poi sono venute le ricette culinarie in dialetto (e, in mezzo, non è da trascurare quel suo
Parole de Vangéle, ossia il rifacimento, la traduzione la “ricreazione” del Nuovo Testamento, della storia e delle parabole di Cristo in una serie di sonetti vernacoli: e non vorremmo trascurare nemmeno la voce che Fraticelli ha prestato a qualche canto popolare, ad esempio al
Sant’Antonio del Coro di Teramo).
Come hanno ad intendersi queste ricette in dialetto?
Non si tratta assolutamente di una pura “messa in versi” di piatti tipici della nostra cucina: c’è anche questo nel libro che oggi vede la luce per i tipi di Marino Solfanelli di Chieti. Ma ci sono soprattutto il gusto, la sapidità, la scienza, la vecchia esperienza che si coagula in saggezza, o se si preferisce, in arte di vivere dell’uomo medio abruzzese, che si rifà a una tradizione ancora capace di guidarlo, di dirigerlo, quest’uomo, tra le complicazioni, le sofìsticazioni dei modelli contemporanei, spesso esterofili.
C’è un personaggio o cui il Fraticelli si riferisce continuamente nel comporre il suo ricettario: e questo personaggio, in bilico tra un registro sentimentale-patetico e un altro ironico-arguto, è la mamma, l’emblema delle mamme d’Abruzzo, di cui, tra le illustrazioni, vive una bella fotografìa. E’ la mamma stessa del Fraticelli che si illumina di un alone di solerzia, di bravura, di praticità, di “economia”·
Nel presentare, tra le minestre, li Tajuline a lu brode,
Raffaele esce a dire, verso la fìne (traduco in italiano e sintetizzo): «Diceva mamma: Non vi prendete furia, mangiate piano; i tagliolini non si mangiano in fretta e con pensieri nella mente, perché ti si mettono per traverso e fanno mancare il fìato!…». E alla fìne di Li gnùcchele de patane: «Oh, quando ragazzi si andava a scuola, mamma. di gnocchi, ne faceva una carriola!…».
Quando io leggo versi e riflessioni del genere, penso che non si tratti solo e sempre in Fraticelli di rimpianto di stagioni perdute, ma che sotto il rimpianto l’autore adombri pudicamente un messaggio, di natura quasi scientifica e dietetica, e che questo messaggio potrebbe esplicitarsi in un discorso che suoni pressappoco così:
Un giorno si campava di minestra, che costituiva la base del nutrimento e che si “scioglieva” nell’organismo e “faceva sangue” come l’ossigeno stesso dell’aria, fusione artigianalmente combinata dei prodotti antichi, autentici, della campagna che ci stava intorno, in cui, anzi, eravamo calati; oggi invece tutto è industrialmente manipolato, e la nostra nutrizione sembra coatta, risultante da un calcolo freddo di proteine, di grassi, di carboidrati, che ci ha tolto la gioia di mangiare e di vivere! Oggi perfino i ragazzi sembrano sottoposti alle “diete atletiche”, si incute in loro precocemente la paura (che è dei genitori) di ingrassare, lo scrupolo di mantenere la linea, di non eccedere, di non perseguire un istinto che è di natura… A un messaggio del genere mi lascia pensare quella “carriola di gnocchi”, vivace e pittoresca, che la mamma ammanniva ai fìgli, per farli nutrire abbondantemente quando andavano a scuola, perché allora si diceva (è un ricordo personale) che nell’età dello sviluppo “sono le ossa a mangiare”. Dunque, la presentazione della mamma nel libro non ha solo una funzione edificante per la memoria, ma è stimolata dal confronto (spesso perdente) della realtà dell’oggi con quella di ieri, allorché la mamma era una sorta di “medichessa”, che tra l’altro sapeva condire con l’allegria il piatto destinato al fìglio. Diventano quasi un leitmotiv, un motivo portante, certe chiuse del Fraticelli. In Sagne e cice … egli sigilla (preferisco sempre tradurre): «La tavola era già pronta, apparecchiata; mamma diceva: Ci sta una improvvisata: ragazzi. oggi sapete che si mangia? Li cumbarucce, sì proprio, ceci e sagne!… ». E in Lu pesce mujecate: «Mamma lo faceva così saporito che sembrava una pizza dolce, un dolcetto di Pasqua: un po’ croccante, la crosticella ti faceva leccare le unghie!». E ancora, in Lu timballe: «A questo punto mamma diceva: San Martino! E si sentiva un odore per la cucina!… ».
Con o senza il ricordo della mamma, il libro del Fraticelli è un monumento elevato alla cucina abruzzese, la descrizione gioiosa di un rito che coinvolge tutta una civiltà: civiltà contadina e artigianale. In una economia non ricca, la “voce” principale era certamente il cibo che il padre di famiglia riusciva a guadagnare per il numeroso nucleo famigliare e che la donna di casa doveva “tradurre” in benedizione di Dio, unica droga ammessa dalla legge per addolcire la vita, così dura e tormentata per molti versi.
Il nostro autore, che ha scritto molte composizioni raffinate per ispirazione e per lingua, si fa quasi uno scrupolo di presentare al pubblico queste “ricette” in un linguaggio dettato alla buona, in versi che spesso esorbitano dalla misura, ipermetri e scazonti, e forse non è pienamente convinto (per modestia, s’intende) che qui egli segue un ritmo veramente popolare: che il suo linguaggio è parlato, che la sua rima non ha una funzione estetica, ma starei per dire “pedagogica”, evocata per ricordare e far ricordare le “specialità”, per collegare non parole, non frasi, ma oggetti, con certe sapide iperboli nella istintiva costruzione della frase che fanno dell’autore un “cantastorie”, un cantastorie appunto della cucina. E, da questo angolo visuale, già l’indice del libro si colloca e costruisce automaticamente come una composizione, un menù poetico, parlato cantato gestito:
– Maccarune a la chetarre
– Tajulìne a lu brode
– Fascìule nghe le còteche
– Gnùcchele de patane
– Lu timballe …
Tutte le composizioni sono state recitate alla radio, in una apposita rubrica settimanale, sono estemporanee e giornalistiche: e non sono state ritoccate per la stampa. Ora, riunite e “trascritte”, non solo esse non perdono il sapore di “salsa piccante”, ma, offerte alla lettura e alla rimeditazione, si accompagnano con illustrazioni che le integrano, che sono il loro contrappunto e la loro glossa visiva. Il Fraticelli ha avuto il gusto, e lo scrupolo, la pazienza certosina, di allineare – in queste foto – gli oggetti di cucina, della casa, gli utensili, sì che le illustrazioni diventano delle mappe, delle carte con didascalia, per riesumare esaustivamente un “clima”, una civiltà, una sapienza, e in definitiva la storia di un nostro periodo di economia domestica. Ciò è stato voluto e realizzato dall’autore in funzione delle nuove generazioni che ormai hanno disconosciuto quegli oggetti per la fatalità del processo culturale, dell’evoluzione, del definitivo decollo industriale: allora a me piace immaginare i giovani, i ragazzi, attenti a questa riesumazione e ricostruzione, ad effettuare le loro “ricerche” (parola ed operazione venute di moda) e sui versi e sulle illustrazioni messe sù sapientemente dal folclorista e quasi archeologo, da quel cantastorie ma anche studioso serio (innamorato della sua Regione) che è il Fraticelli.
Il libro è, da tutti i punii di vista, una ghiottoneria: e chi sta vergando queste righe di prefazione è il primo a gustarsi per suo conto gli odori e i sapori della cucina annerita dal fumo (anche il fumo, a rigore, è un personaggio oggi scomparso), della fiamma, del “fuocolento”, strumento indispensabile per fare un buon cuoco: di tutta l’aria, del clima (come abbiamo accennato) che si sprigiona da un passato che, da prossimo, sta diventando irreparabilmente remoto.
INDICE
minestre
La cene de la Viggilie, 17
Maccarune a la chetarre, 19
Tajuline a lu brode, 21
Fasciule nghe le còteche, 23
Li gnùcchele de patane, 29
Lu timballe, 32
Sagne e cice, 35
Sagne e fasciule, 36
Paje e fiene, 38
La pulente, 41
Lu risotte de nonne, 43
La pasta reale, 45
Maccarune nghe lu suche de tonne, 47
Ravïule de recotte, 49
Spaghitte a la carbunare, 51
Crocchette di rise, 5 7
Screppelle ’mbusse, 59
Maccarune nghe le vongole, 61
Maccarune a la matriciane, 63
verdure
Carciufenette ’ndurate e fritte, 67
Scarole nghe caçe e ove sbattute, 69
Pipidìnie aripiene, 71
Mulignane a la parmiggiane, 73
Mulignane a funghitte, 75
Checuccelle aripiene, 77
Sfurmate de checuccelle, 79
Carciòfele nghe lu bruschette, 85
Rise e virdure a lu brode, 87
Quadrucce e piscille, 89
Pulente e fave, 91
Fasciulitte e patane, 93
Paste, patane e checuccelle, 95
Lu ministrone, 97
La linticchie nghe lu pane fritte, 99
Vrùcchele strasscenate e savicicce, 101
Rise e fasciule nghe la cepolla zuffritte, 103
Càvele di fiure zuffucate, 105
Li miniscurde, 107
Li miniscurde cotte e cunzervate, 108
Lu lazzarette, 113
carni
Pulpette nghe contorne de cepullette agro-dolce, 119
Lu rolle de carne di vitelle, 121
La trippe, 123
Fettine de hallenacce, 125
Li ’ndriùle d’agnelle, 127
Li turcinille, 129
Lu suchette a la genovese, 131
Lu cunéje aripiene, 134
pesce
Lu baccalane, 143
Rusciulitte aripiene, 145
Sgùmbere oje e limone, 147
Lu pesce mujecate, 149
Le frittelle de pesce a rise, 151
Cìammajchelle de mare, 153
uova
La frettata maretate, 159
Ove fritte nghi li bastardune, 161
Ove nghi pipidinie e pummadore, 163
dolci
La cicirchiate, 171
Le zeppele de San Giuseppe, 173
Lu fiadone, 175
Caviciùne di cice, 177
Lu sanguenate, 179
Lu taralle de Sande Biasce, 181
Tarallucce de mezza Quarèseme, 183
Pupe e cavalle de Pasque, 185
Pezzelle nghe la marmellate, 187
appendice
La Panarde, 195
Brindisi, 201
GLOSSARIO, 207